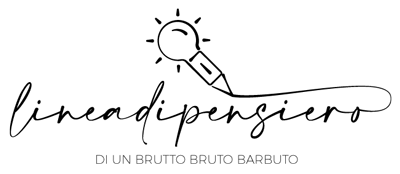Mi sono ripescato più volte nella vita.
Non è mai accaduto all’improvviso, come nei film, con una mano tesa da una barca al momento giusto. È stato piuttosto un gesto lento, goffo, quasi ridicolo. Nel portare la canna indietro per lanciare l’amo, questo si è agganciato al cappuccio della felpa. Io che mi afferravo da solo, riprovando, senza sapere bene da dove tirare. Finché, dimenandomi per sganciarmi, sono caduto in acqua.
L’acqua non aiutava la presa della lenza e dell’amo da sganciare. Era ogni volta diversa. A volte gelida e violenta, a volte ferma, stagnante, così quieta da convincermi che forse non stavo affondando davvero.
Mi sono ripescato quando ho smesso di riconoscermi nelle cose che dicevo di volere. Quando ho smesso di scegliere me, quando parole come abitudine e sicurezza avevano preso il posto di desiderio. In quei momenti restare a galla sembrava inutile. Nuotavo, sì, ma in tondo. E così ho toccato il fondo non per mancanza d’aria, ma per eccesso di immobilità.
Il fondo è comodo, se ci pensi. Non devi decidere nulla, non devi guardare lontano. Ti adagi. Riposi. Anche se la sabbia negli occhi brucia ed è piuttosto buio.
Poi arriva uno strattone violento che lacera la felpa.
Ripescarsi significa anche questo.
Accettare lo strappo.
È l’istante in cui capisci che per tornare su devi perdere qualcosa. Un’idea di te, un ruolo, una promessa fatta troppo in fretta. Ogni risalita mi ha lasciato addosso un segno, come sale sulla pelle. Non cicatrici da esibire, ma punti sensibili, pronti a ricordarmi che posso ancora cadere.
Col tempo ho imparato a sentire le correnti prima che diventino tempesta con il rischio di rimaner impigliato negli scogli. Mi muovo perché il vento e il modo del mare cambia, e io con lui.
Non è incoerenza, è ascolto.
Adesso è ora di tornare su con la consapevolezza che mi ripescherò ancora.
Non perché sia forte, ma perché ho smesso di vergognarmi di farlo.
E forse è questo, alla fine, il mio modo di restare vivo.
Lineadipensiero ripescata