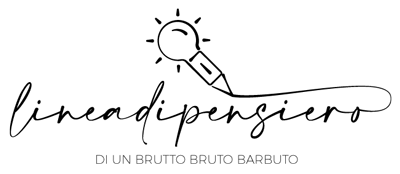Conosco il silenzio. A volte porto sicuro, altre rifugio altre ancora caverna buia.
A volte, raramente, ho avuto il piacere di accoglierlo nel suo stato più intimo. In un abbraccio. Che è un abbraccio a me stesso. E lasciavo ogni mia armatura o pregiudizio per farmi abbastanza piccolo da esserne avvolto. E tutto intorno diviene ovattato come fossi chiuso in una campana di vetro da cui non vuoi uscire finché c’è sufficiente ossigeno per rimanere dentro. Le mie mani si stringono a coprire i miei occhi lucidi di lacrime lasciando un rossore sul viso che potrei giustificare con l’imbarazzo di un imbarazzante momentaneo momento.
È ora di uscire. Sollevo la vitrea separazione per andare non so dove ma certo che una strada ci sia.
Muovo i pensieri alla ricerca di una quiete e attraverso il caos delle parole dette e di quelle non dette ascoltando empaticamente ogni linguaggio non verbale e ogni sottointeso.
Resto. Ascolto. Muovo. E poi…
…e poi mi capita di finire in quella caverna, senza un acciarino per dar vita ad una fiamma che possa farmi luce e scaldarmi. Cerco due pietre per creare quella scintilla che mi possa spiegare come uscire. Cerco quella riconnessione neuronale che possa svelarmi dove metter le mani nel mio procedere a tentoni. I tagli sulle mani e le ginocchia indolenzite mi ricordano quant’è dura la via.
Resto. Silente. Immobile.
E poi non so andare oltre, ma vorrei abbracciarmi.